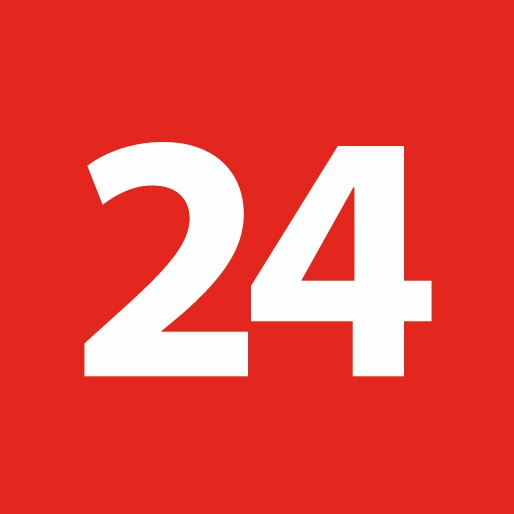Ha compiuto 25 anni la Legge 482 sulle minoranze linguistiche

La celebrazione del venticinquennale da parte di Uncem, con alcuni suggerimenti attuativi concreti
La Legge 482 nasce in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali. Essa riconosce l’esistenza di dodici minoranze linguistiche definite “storiche” attribuite a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e ne ammette a tutela le rispettive lingue (albanese, catalana, croato, francese, francoprovenzale, friulano, germanico, greco, ladino, occitano, sardo, sloveno). Queste dodici lingue minoritarie, parlate in delimitazioni territoriali riconosciute di 14 regioni italiane, sono appunto tutelate da apposite leggi nazionali e leggi regionali e delle province autonome.
L’Unione Nazionale comuni e Comunità Montane spiega: “Noi di Uncem crediamo da sempre e sosteniamo la 482, che protegge la biodiversità linguistica, dà forza alle nostre “Lingue madri” con 2.400.000 parlanti distribuiti in 1.171 Comuni di 14 regioni
A occuparsi della 482, a livello centrale statale, è il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DARA – e dunque il Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie oggi guidato da Roberto Calderoli, Ministro che si occupa anche di Montagne e Green Communities.
Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche ogni anno viene ricostituito con la Legge di Bilancio. Non deve diminuire. Attraverso la ripartizione del Fondo, sono finanziati i progetti presentati dalle Amministrazioni statali, territoriali e locali volti a consentire, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.”
“Abbiamo molto da fare per tutelare e rilanciare la biodiversità linguistica del Paese – evidenzia il Presidente nazionale di Uncem Marco Bussone – e lo dovremo fare con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali attenti e lungimiranti sulle lingue. Dobbiamo farlo con tante Associazioni che ci credono. La cultura è questa, per la montagna e per i territori. Le lingue madri generano appartenenza, autonomia nella coesione e nell’unità territoriale del Paese. Le lingue non sono solo ‘minoritarie’ bensì ‘madri’, cuore pulsante culturale dei nostri territori alpini e appenninici. Due fronti principali del lavoro da fare nei prossimi anni, dopo i primi venticinque anni della 482. Dobbiamo lavorare sulle scuole, sulla formazione in classe delle nuove generazioni, e sui media. Secondo, c’è pochissimo spazio sulla tv pubblica per le lingue madri. Troppo poco, niente. La RAI deve fare di più. Si attivino Dirigenti, tutti i Vertici e rispettino la legge. Nel nuovo contratto di servizio serve un’adeguata valorizzazione e promozione. C’è in ballo il futuro di un bagaglio storico che nessun altro Paese del mondo ha e conosce”.
Va ribadito che l’Italia ad oggi non ha ancora ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un documento importantissimo elaborato nel quadro del Consiglio d’Europa per proteggere i diritti delle minoranze etniche, anzitutto quello di tenere viva la loro cultura. La portata delle disposizioni della Carta va oltre la semplice protezione delle minoranze e la tutela contro la discriminazione, poiché richiede che gli Stati firmatari adottino attivamente misure efficaci per la promozione delle lingue minoritarie. Concepita nel 1984 durante un summit al Palais de l’Europe a Strasburgo, poi formalizzata nel 1992, è ufficialmente entrata in vigore nel marzo 1998. Che l’Italia non l’abbia ancora ratificata appare tanto più sorprendente se si tiene conto che la stessa Costituzione italiana spinge a riconoscere e a tutelare le lingue e le culture minoritarie.
 0
0